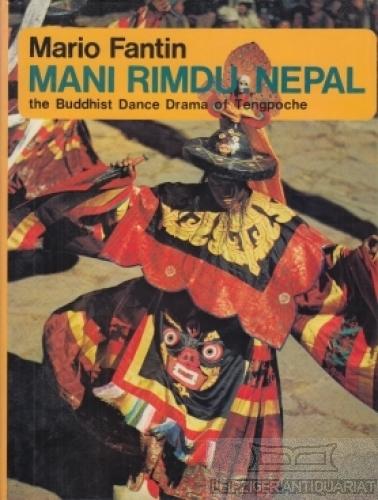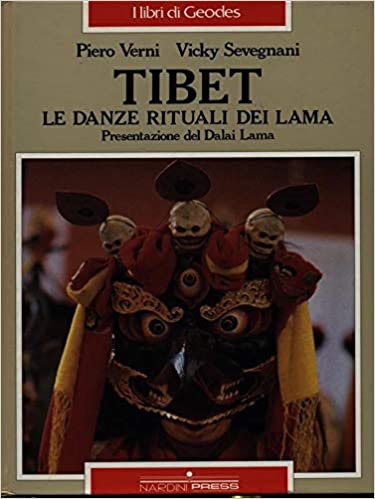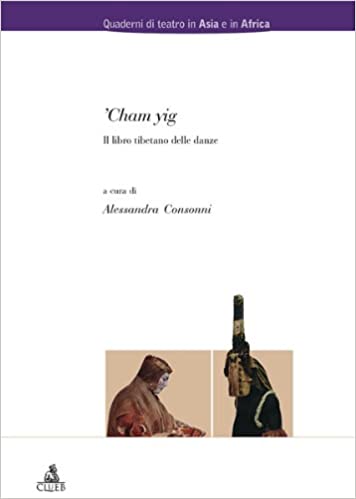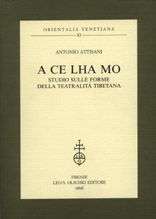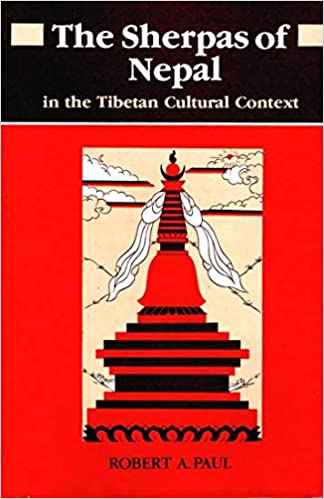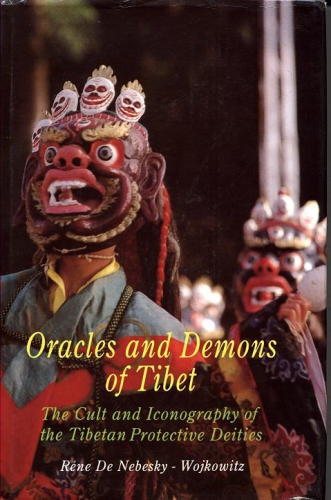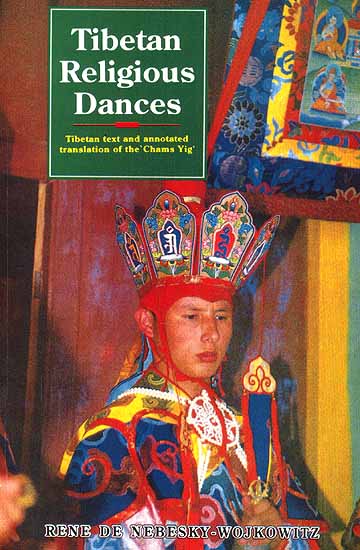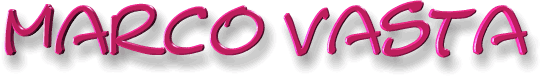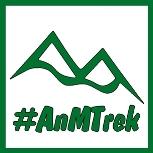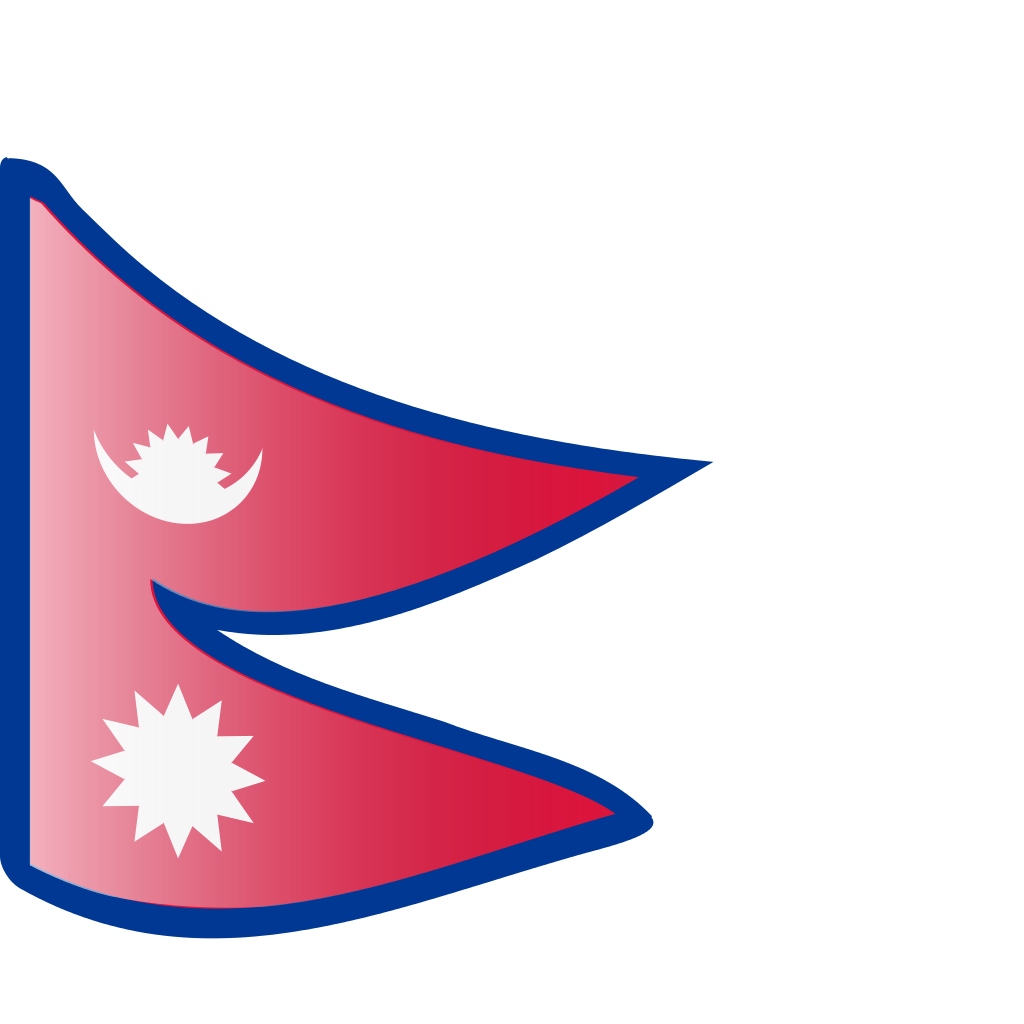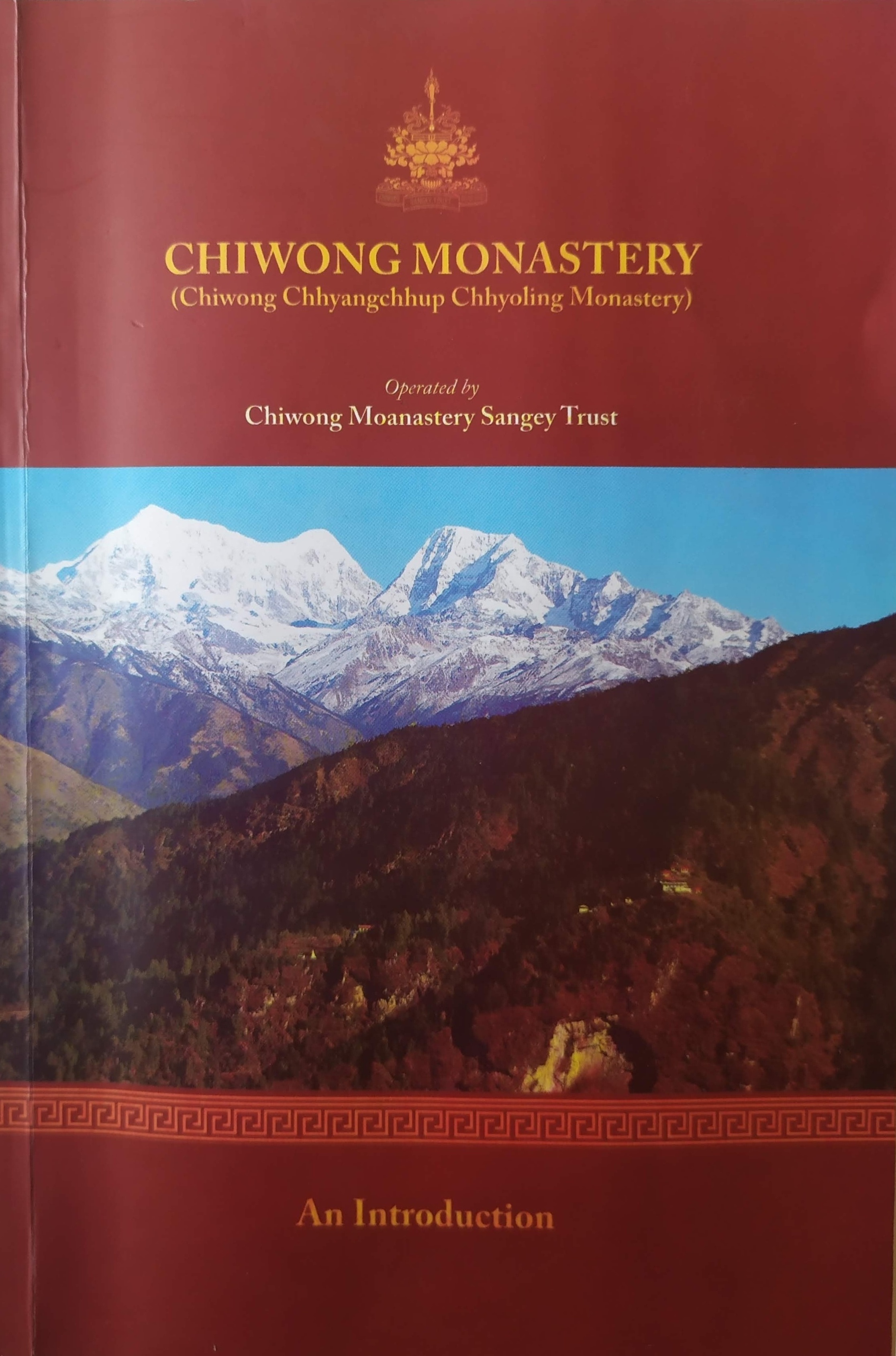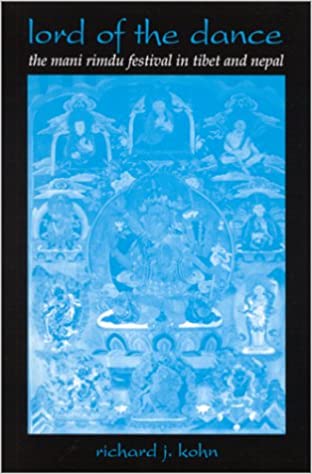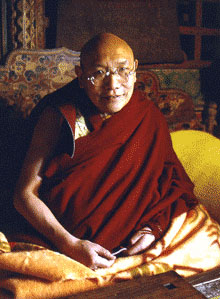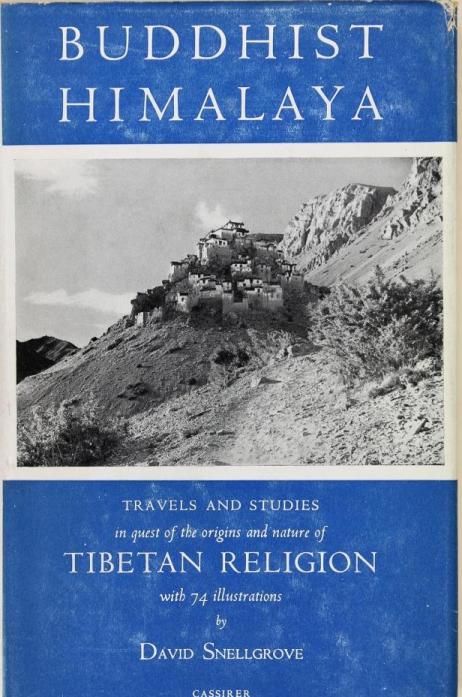|
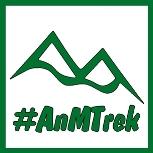 |
31 ottobre - 16
Novembre 2019
con AnM e Marco Vasta nel paese degli Sherpa in occasione del Mani
Rimdo
"Se non sali la montagna, non
potrai ammirare il paesaggio" Paolo Neruda
|
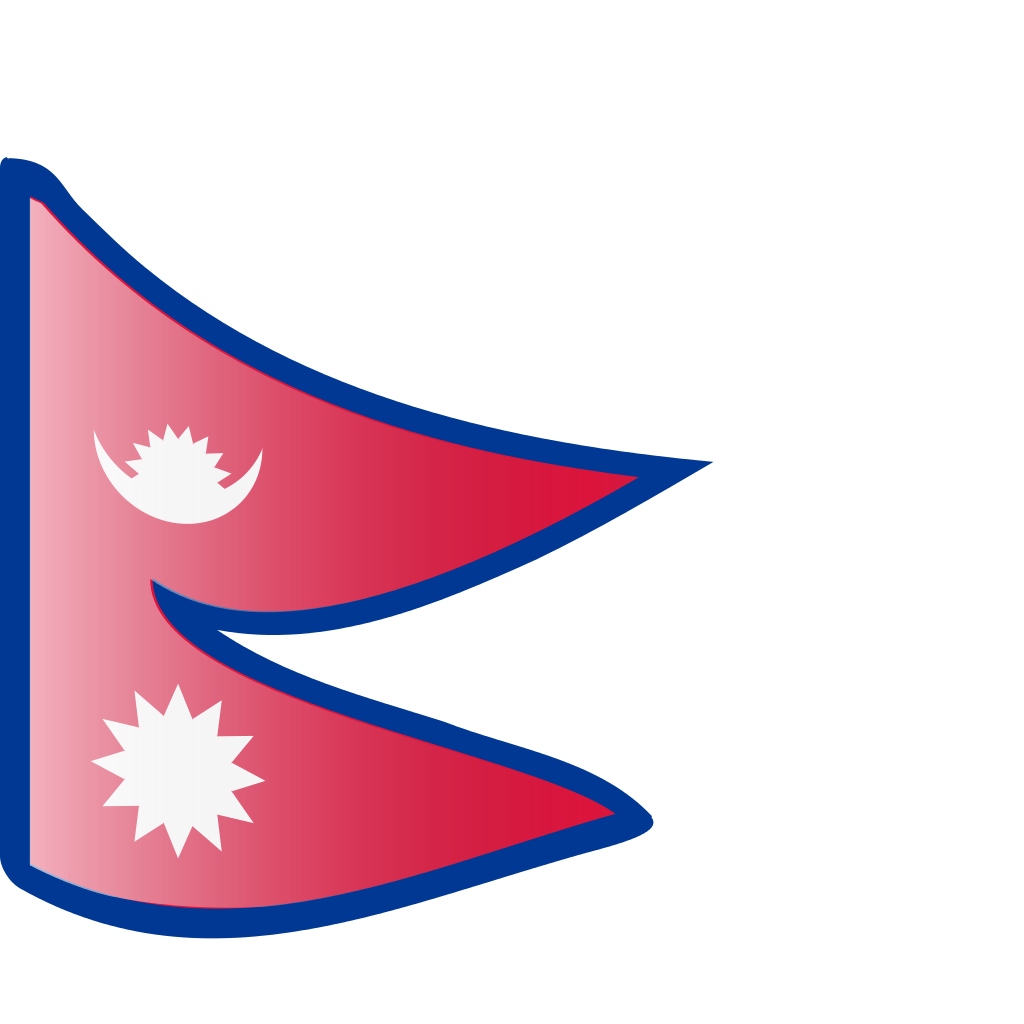 |
Mani Rimdu
al Monastero di Ciwòng
[ Cham - le Danze ]

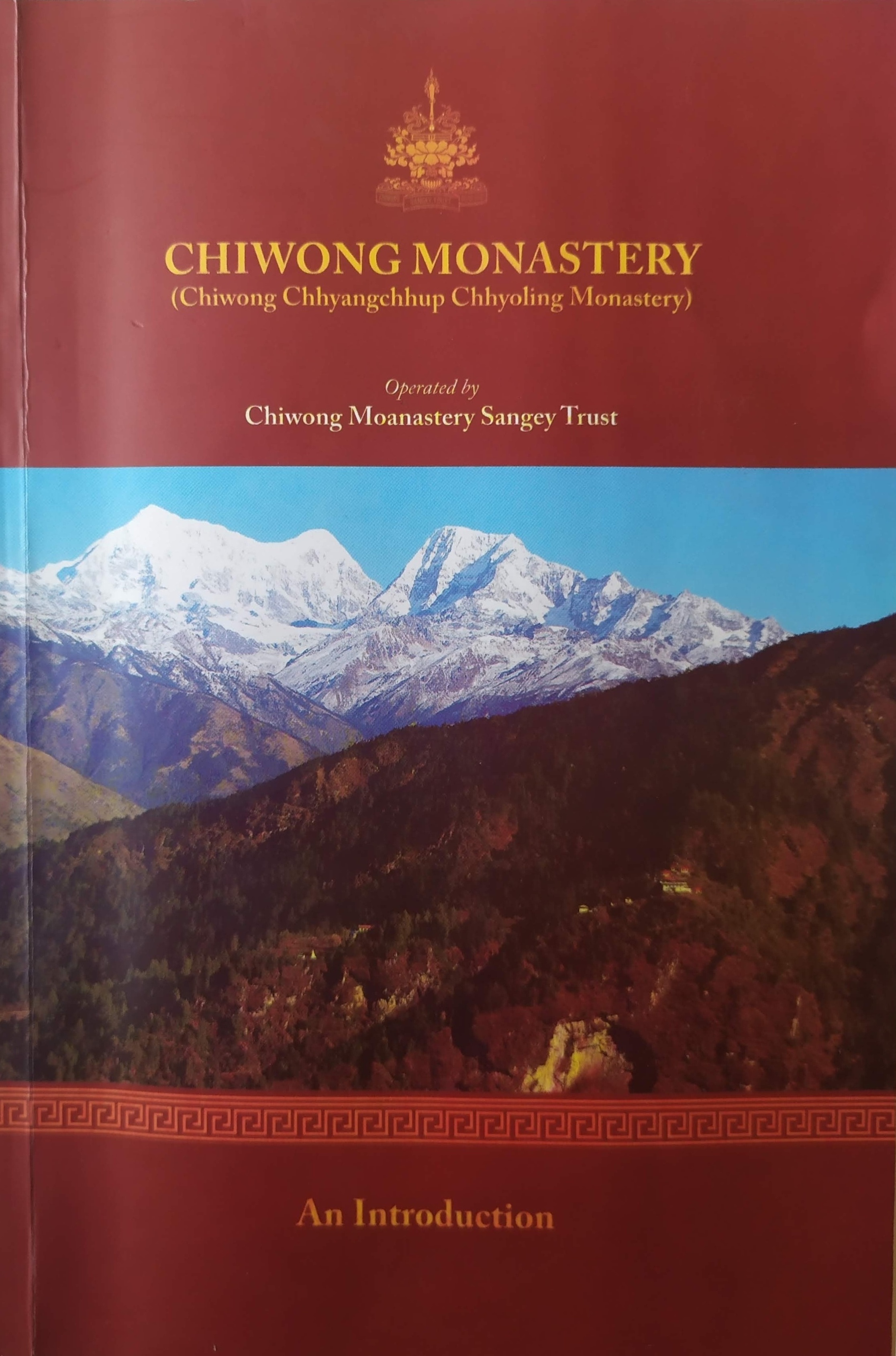 |
|
Ciwong Monastery Sangay Trust
An Introduction |
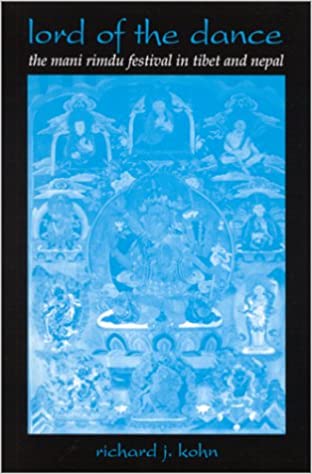 |
|
Lord of the Dance
The Mani Rimdu Festival in Tibet and Nepal
di Richard J. Kohn |
Chiwong è stato fondato nel 1923 da Sangye
Tempa Lama, un ricco sherpa di Solu, che ha donato gran parte delle
terre di famiglia per erigere il monastero. Secondo la tradizione, egli apparteneva alla undicesima generazione di discendenti di
Sherwa Dungyal, figura storica, che nel 1530 guidò la migrazione degli
sherpa (sher-wa, gli uomini dell'est, forse kham-pa) dal Tibet al Khumbu
attraverso il Nagpa-la (su date della migrazione e luoghi vengono formulate
varie ipotesi).
Le riforme fondiarie del governo nepalese hanno
ridotto notevolmente il latifondo, ma Chiwong rimane uno dei pochi monasteri
in Nepal in grado di fornire ai suoi monaci un'indennità di grano che è
anche un
grande sostegno per le famiglie più povere.
Ang Babu,
nipote di Sangye Lama e attuale patrono di Chiwong, ha ereditato la
dimora privata e il tempio di famiglia sui terreni di Chiwong, così come la
casa a Phaplu. Lui e la sua famiglia occupano i posti d'onore al
festival Mani Rimdu.
L'ispirazione per fondare dei monasteri a Solu Khumbu venne da
Ngawang Tenzing Norbu, abate di Dza-Rong-Pbu
Gompa (fondato 1923) ai piedi del Chomolungma (Monte Everest) in
Tibet. Il suo desiderio venne esaudito da Trulzhig Rinpoche il
cui nome significa "Prezioso
distruttore di illusioni".
Trulzhig Rinpoche nacque Tibet, a Lo Talung,
un luogo sacro alla dea Tara. Quando aveva quattro anni, fu riconosciuto
dall'abate Ngawang Tenzing come la reincarnazione del suo lama del cuore,
Trulzhig Tendru Dorje.
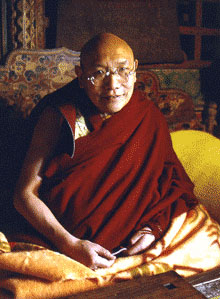 |
Trulzhig Rinpoche
nel 1986
a Thubten Cheling |
Trenta delle precedenti incarnazioni di Trulzhig
Rinpoche erano vissute in India, una delle quali era Ananda, il
discepolo del Buddha che lo avrebbe persuaso a permettere alle donne di
prendere l'ordinazione e unirsi al Sanga. Questo fu un passo molto
radicale nella società dell'antica India, anche se sembra che ci sia voluto
un concilio per farlo accettare da tutti...).
Diciassette delle precedenti incarnazioni di
Trulzhig Rinpoche nacquero in Tibet, incluso Rechung-pa, uno dei principali
discepoli del grande poeta e mistico Milarepa. Secondo la leggenda del
regicidio. Rechung-pa apparve anche come Lalung Pelgi Dorje (
Lha-lung dPald-gyi-rDo-rje
ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ)
che pose fine al regno di terrore del re gLang-dar-ma che stava
sistematicamente uccidendo tutti i praticanti buddhisti in Tibet. Pelgi
Dorje eseguì la danza del cappello nero
davanti al sovrano, nascondendo una freccia nelle ampie maniche della sua
veste. Per compassione sia per le vittime che per il re che nelle future
incarnazioni avrebbe sofferto tutto il dolore che ora sarebbe stato inflitto
agli altri, il monaco estrasse la freccia dalla manica e uccise il re.
Trulzhig Rinpoche studiò in diverse università monastiche e con
famosi insegnanti. Nel 1959, quando il XIV Dalai Lama fuggì
dall'occupazione cinese del Tibet, anche Trulzhig Rinpoche fuggì a sud
attraverso l'Himalaya. Rimase un anno nel monastero di Thame, poi si
trasferì a Chiwong. Successivamente fondò un gompa a Sengye Pubk (la
'Grotta del Leone', sopra Thubten Choeling, sui pendii inferiori di Sborung
Yul Lba), dove studiano e meditano centotrenta monaci e monache. Dopo avere per
anni presieduto al 'Cham, Trulzhig Rinpoche. è spirato nel 2011.
Dal
1995 i riti del mai Rimdu vengono officiati da Sang Sang Rinpoche. La
complessità dei riti ed la cadenza delle giornate è stata descritta
accuratamente in Lord of the Dance: The Mani Rimdu Festival in Tibet and Nepal
di Richard J. Kohn, che ha anche prodotto i due documentari Lord of the
Dance: Destroyer of Illusion e Destroyer of Illusion: The Secret
World of a Tibetan Lama.
Torna
all'inizio
Nei suoi "pellegrinaggi" nel 1953 e 1954, il
Prof. Snellgrove visitò lo Shar Khumbu e ci ha lasciato una vivida
descrizione di Chiwong (da lui scritta Jwòng, tib: spyi-dbang
"Consacrazione dell'Universo"). Nel capitolo Tibetan Cerimonies, il
lhakang, tempio principale del gompa, è presentato come secondo per
importanza solo a Tengboche e Snellegrove ne elogia l'armonia della sala e
la pratica religiosa.
Snellgrove dedica al gompa diverse pagine di
Buddhist Himalaya, Travels in Quest of the Origins of Tibetan Religion (Bruno Cassirer,
1957). La descrizione delle pareti del tempio, permette
all'autore di illustrare l'iconografia delle divinità rappresentate e,
riportando i rituali dei monaci, inserisce la traduzione di canti, preghiere
e mantra (formule).
Snellgrove incontra anche un giovane
reincarnato, aspirante al titolo di abate di Rongbuk, ed accenna alla disputa sul
riconoscimento di uno dei due
tulku
(rincarnati). Alla fine venne scelto quello nato in Tibet e non quello autoctono nato in Solu.
La vicenda è ampliamente raccontata nel'opera di
Christoph Von
Fürer Haimendorf The Sherpas of Nepal, Buddhist Highlander (1964),
la miglior ricerca sul campo ed un classico della letteratura himalayana.
Chiwong del 1955 è sicuramente differente da
quella da noi visitata. Settantacinque anni dopo, non solo orami è raggiunta
da una strada sterrata, ma addirittura una piazzola dove può atterrare
l'elicottero di uno dei munifici sponsor del monastero. Per leggere
Buddhist
Himalaya in PDF, clicca qui.
Torna
all'inizio
Reso famoso dall'evento periodico autunnale nel
monastero di
Tengboche,
anche Chiwong ha un suo Mani Rimdu nelle stesse date propizie. Mani Rimdu è una sequenza di diciannove giorni di
cerimonie sacre e di potenziamento mentale e spirituale, che culmina in una festa pubblica di
tre giorni. Per le comunità locali sherpa e tibetane è l'occasione di
riunirsi e celebrare i riti insieme alla comunità monastica.
Mani Rimdu è la ricostruzione di eventi
leggendari come l'istituzione del Buddhismo in Tibet da parte del grande
santo, mago e taumaturgo
Guru Rinpoche,
il Prezioso Maestro, गुरु रिनपोचे (Skt: Padma
Sambhava, nato da loto, पद्मसम्भव : Tib: པདྨ་འབྱུང་གནས། pad ma 'byung
gnas ). Considerato il Secondo Buddha dall'ordine
Nyingma che regge il monastero. Attraverso le danze, i demoni vengono
conquistati, sottomessi e convertiti in protettori del Dharma,
mentre le forze positive si scontrano con quelle del caos. Le danze
trasmettono insegnamenti buddhisti su molti livelli - dal più semplice al
più profondo - per coloro che non hanno l'opportunità di studiare e meditare
ampiamente.
Torna
all'inizio
Un saggio specifico sul Mani Rimdu è a pagina
109 del capitolo V di
The Sherpas of Nepal in the Tibetan Cultural
Context: (The Tibetan Symbolic World: A psychoanalytic Exploration) di
Robert A. Paul.
 |
Un monaco
distribuisce le
mani rilwo agli Shanang |
Il libro è uno studio psicoanalitico del popolo
sherpa anche attraverso la descrizione e l'interpretazione delle danze, ma
un capitolo è dedicato appunto al cham di Tengboche e di conseguenza
contiene riferimenti anche a quello di Chiwong. Paul si confronta con lo
studio etnografico di Luther G. Jerstad cui fa spesso riferimento. Secondo
Paul il nome deriva dalle "pillole sacre", le mani rilwo. In tibetano
vi sono molte consonanti "mute", rimaste nella scrittura ma non più usate
oralmente e nel tempo la pronuncia originaria di Ma-ni ril-sgrub si è
modificata. Dalla invocazione "Om mani padme hum", mani ha una
connotazione di sacralità che permea gli oggetti cui viene preposta come ad
esempio le ruote di preghiera mani-khorlo. Ril-bu indica una
pallina od una pillola mentre sgrub significa non solo
"ottenere" la benedizione di un dio ma anche di "possedere" questa
protezione (Tibet English Dictionary di Heinrich August Jäschke).
Nel 2019 il cham si è svolto nel 16° giorno del
9° mese tibetano (13 novembre 2019) sotto il segno delle Pleiadi. Mani Rimdu
inizia il primo giorno e
dura fino al diciottesimo giorno del nono mese tbetano. Dall'inizio fino
alla fine del festival, i monaci eseguono puja (rituali) 24 ore su 24 per
consacrare il Mandala, le Mani Rilwu (pillole sacre), le
Tshereel (pillole per una lunga vita) e le Torma.
Torna
all'inizio
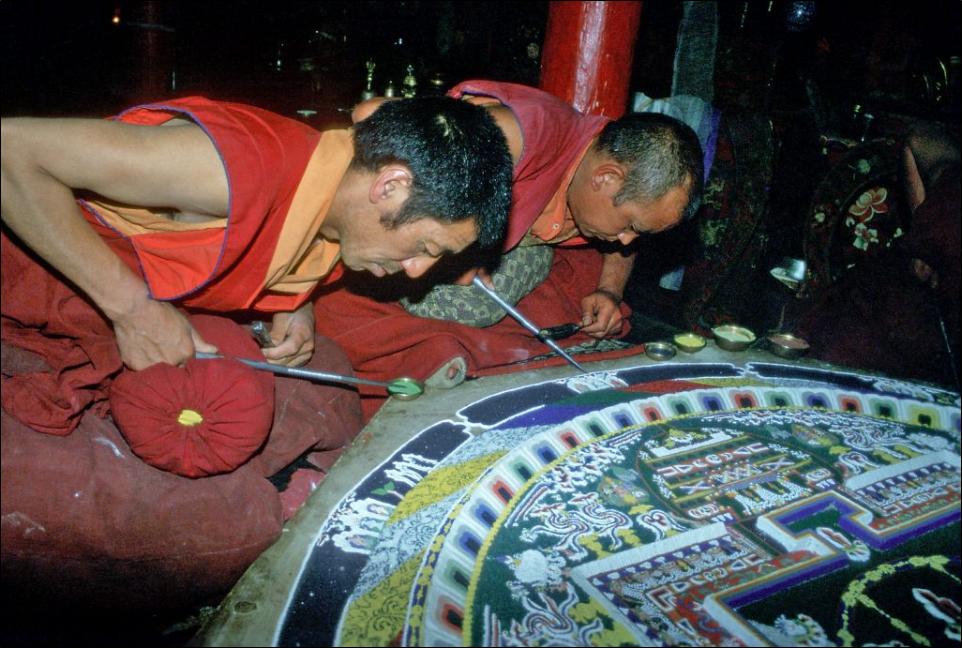 |
Hemis
1985
Il mio primo mandala |
Il mandala (“cerchio” in sanscrito, tib. dKyil-‘khor) è costruito con cura, granello per
granello, da sabbia colorata. Un disegno intricato e simbolico che richiede
molti giorni per essere completato. Le divinità protettive del pugnale (phurba)
sono posizionate intorno al Mandala e la ciotola di pillole Mani Rilwu
(medicina spirituale) è posta sopra il centro.
Il Mandala diventa il Palazzo di Garwang
Thoze Chenpo, il Signore della Danza, un'emanazione di
Chenrezi, il
Buddha della compassione, divinità centrale di Mani Rimdu, protettore del
Tibet e di cui il Dalai Lama è una manifestazione. È uno psicogramma
dell'universo, ne spiega l'organizzazione. La sua costruzione è parte
integrante della liturgia ed è un momento di concentrazione e meditazione
per l'artista. Il sacro cerchio è disegnato su una superficie piatta ma
dobbiamo immaginarlo tridimensionale.
Il mantra "Om
Ah Hung Rhi, Om Mani Padme Humg", viene
ripetuto migliaia di volte dai monaci durante le settimane della cerimonia
che precedono il festival pubblico. Durante la loro meditazione,
visualizzano la compassione che scorre nella forma del mantra, nelle pillole
Mandala e Mani Rilwu. La compassione si irradia poi dal Mandala, benedicendo
tutti coloro che partecipano al festival Mani Rimdu. Le celebrazioni ruotano
intorno al mandala ed il Mani Rimdu comincia con la sua realizzazione e si
conclude con la distruzione dopo la puja del fuoco.
Torna
all'inizio
Il Wong è la cerimonia pubblica di apertura. Si
svolge nel giorno della luna piena, del decimo mese nel calendario lunare
tibetano. Sua Santità Trulshig Rinpoche, dà il "potere" in questa
occasione propizia per lunga vita, felicità e prosperità. Le sacre Mani Rilwu (pillole sacre) e
Tshereel (pillole per una lunga vita) sono date a
tutti i presenti.
Per tutta la giornata, assieme ai riti che si
svolgono nel tempio, i fedeli portano i loro regali (offerte) al monastro. È
una cerimonia lunga e noiosa, per questo i turisti preferiscono presenziare
solo alle danze del secondo giorno.
Wong o wang si può tradurre come iniziazione o
potenziamento (Skt. Abhiseka o abhisiddhi. Tib. དབང་, Dbang, Wang) o
concedere un potenziamento (Skt. Abhiṣiñca ;. Tib དབང་ བསྐུར་ བ་) e si
riferisce al rituale Vajrayana che risveglia la speciale capacità di far
sorgere nella mente del discepolo la saggezza primordiale (Tib. yeshe ). Si
chiama "potenziamento" perché quando lo riceviamo, abbiamo il potere di
seguire una particolare pratica spirituale, e così arriviamo a
padroneggiarne la realizzazione.
Torna
all'inizio
Le danze si svolgono il 2 ° giorno di Mani
Rimdu (vedi pagina seguente).
La Puja viene eseguita nel cortile il giorno
dopo le danze. La maggior parte della gente del villaggio è andata a casa e Chiwong ha un'atmosfera tranquilla, quasi familiare. La
Puja
è un'offerta ad
Agni (il dio del fuoco) e per gli dei del mandala - per alleviare ogni
danno nel mondo. Il danno viene visualizzato come dissoluzione nel grano e
il burro viene bruciato.
Successivamente, il mandala di sabbia nel tempio
viene smantellato e la sabbia data come offerta agli dei serpenti (Naga),
nella prossima primavera in un luogo sotto il monastero.
È molto difficile rispondere alla domanda su
come siano nate le danze 'cham, tuttavia si può sostenere che nelle forme
attuali le danze culturali del lamaismo siano indubbiamente una sintesi dei
costumi originali tibetani con i concetti e le pratiche del tantrismo
indiano. Secondo le tradizioni orali e del 'Cham yig, talvolta gli autori
delle danze le hanno create partendo sia da princìpi cosmologici e
iconografici generali che da visioni avute in sogno, in accordo con gli
insegnamenti religiosi delle rispettive scuole. Si ritiene generalmente che
alcuni creatori di danze abbiano inventato i movimenti coreografici dopo
aver visitato in sogno la Montagna di Rame Colorato (zangs mdog dpal ri)
della leggenda di Padma Sambhava.
I Cham di
Chiwong e di Tengboche hanno però differente struttura da quelle Ghelug-
Torna all'inizio
In specifico, il 'cham dell'ordine Ghelug-pa
viene dettagliatamente descritto nel codice 'Cham yig.
L’introduzione del libro fornisce indicazioni dettagliate sugli autori. La
maggior parte del testo è stata scritta dal Grande Quinto, Ngawang Lobsang
Gyatso (Nagag dbang blo bzang rgya mtsho) (1617-1682), conosciuto con il suo
“nome segreto” o pseudonimo di Zha hor gyi bandhe o anche Bla ma rdo rje rtsal.
Egli inizio la stesura del libro nel IV mese del 1647, anno del Maiale di Fuoco,
e lo destinò ai preti del monastero rNam par gtal ba’i phen bde legs bshad gling,
più brevemente Namgyal Gompa (rNam rgyal dgon pa), la lamaseria interna
del Potala, che viene ripetutamente citata nel terzo capitolo.
Il testo comprende una raccolta di scritti del Grande Quinto, ma purtroppo
rimase incompiuto. Importanti lama cercheranno di completarlo. Nel 1709,
l’incarico venne affidato ad un
tulku e poi ad altri due lama per essere
finalmente messo alle stampe a Ganden nel 1712. Anche se l’autore era la più
alta autorità Gelug-pa, il testo fa riferimento principalmente alle tradizioni
Nyingma e Saskya. Questo sincretismo non deve stupire in quanto il Grande
Quinto nasceva da una famiglia di rito Nyinma e che spesso i Dalai Lama, come
l’attuale XIV, sono persone di ampie vedute e non settarie.
Il
V Dalai Lama ed i tre co-autori spiegano la metodologia di lavoro nelle ultime
pagine del testo che ha cercato di unificare le varie modalità di danze in onore
di Vajrakīla, l’yddam principale protagonista delle danze contenute nel
libro. Vajrakīla è un Heruka, molto importante nelle tradizioni nyingma e saskya, spesso raffigurato con tre teste, sei braccia e quattro gambe, ma che
soprattutto impugna il kīla (tib: phur ba), uno dei potenti oggetti del rituale.
Vajrakīla è la emanazione, tramite una serie di passaggi, di Samantabhadra, che
compare nel titolo e che è nominato anche all’inizio quando il Grande Quinto
specifica musica e gestualità. Le danze simbolicamente replicano il mandala di
Vajrakīla che simboleggia la costruzione del suo palazzo, passano poi ad altri
movimenti, fra i quali l’evocazione di 64 divinità minori della sua corte, la
creazione della sakti, la sua consorte, o compagna: ‘Khor lo rgyas ‘debs ma (il
prof. Tucci usa il termine paredra (2).
Il
manuale, o canone delle danze, prosegue descrivendo minuziosamente i paramenti,
i gesti e gli oggetti (Tucci li definiva “parafernalia”) impugnati dai “cappelli
neri” e degli altri protagonisti, per poi descrivere le tre fasi del cham.
Gli autori spesso citano le fonti, e la più importante compare subito all’inizio
nel rito del mandala di Vajrayana che ha due sezioni e nella seconda si fa
riferimento alle scuole Sarma e alla danza sviluppata dal grande Bu Ston (Butön
Rinchen Drub) “che aveva conoscenza di tutte le danze” e traeva le sue
conoscenze dall’antico testo mKha’ ‘gro rdo rje gur e da pratiche di
concentrazione dello yoga.
Torna
all'inizio
Note
(2) Dal greco "para"=presso ed "edra"=sedia, ha il
significato di "che siede accanto". Nella religione greca, infatti, si dava
questo nome ad una divinità associata al culto di altra divinità. La
consuetudine fu mantenuta anche dai Latini. Presso gli Hindu esiste una
forma similare ma con significato diverso; ogni Dio, infatti, ha una
corrispondente figura femminile che, di solito, prende il nome di Shakti.
Bibliografia sul Cham
L'interesse per i Cham nasce in Italia grazie a due
libri quasi introvabili:
Mani Rimdu Nepal:
the Buddhist Dance Drama of Tengpoche di
Mario Fantin, New Delhi 1976 .
Non a caso Fantin pubblicò
in lingua inglese temendo la scarsa diffusione fra il pubblico italiano.
Tibet le danze
rituali dei lama
di
Piero Verni con immagini di Vicky Sevegnani ,
riedizione di un libro edito da Jaka Books
negli anni 80.
Per cercare di comprendere i Cham, ho anche
acquistato e consultato:
Oracles and Demons of Tibet, the cult and iconography of the tibetan
protective Deities, di René De Nebesky-Wojkowitz, 1956.
Tibetan Religious Dances. Tibetan Text and Annotated Translation of
the "Chams Yig" di René De Nebesky-Wojkowitz, 1976.
'Cham yig, Il libro tibetano delle danze, a cura di Alessandra Consonni.
Esula dal nostro
argomento, ma riguardo alle espressioni artistiche tibetane segnalo:
Ace lha mo. Studio sulle forme
della teatralità tibetana di Antonio Attisani (2001) .
|