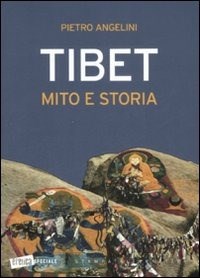 Tibet mito e storia
Tibet mito e storia

Contributo della dott.ssa Chiara Bellini
Sono rari i titoli disponibili, in lingua italiana, sulla storia tibetana e le sue vicende politiche e religiose. Da tempo, infatti, gli studi sull’Asia Centrale sono scritti in lingua inglese, per consentirne la diffusione, soprattutto negli ambiti accademici, a livello internazionale. Approfondire argomenti di carattere storico, letterario, linguistico, artistico, in ambito tibetano, può risultare difficile per chi non abbia determinate competenze linguistiche. Tra i pochi titoli di valore scientifico, disponibili in lingua italiana, di carattere storico-culturale, si annoverano le opere di Giuseppe Tucci, Rolf Stein, e David Snellgrove, sebbene la sua opera capitale, The Cultural History of Tibet, scritta insieme a Hugh Richardson, sia stata tradotta in italiano disastrosamente dalla casa editrice Luni, con il risultato di un testo inutilizzabile in ambito accademico, che non rende giustizia all’originale e soprattutto al talento dei due autori (vedi "Tradurre o tradire? Recensione critica di Erberto Lo Bue" - News letter N° 21 - Dicembre 2005).
Ecco, ora, affacciarsi sul panorama degli scritti tibetologici in lingua italiana, Tibet Mito e Storia, dell’“orientalista” – come viene presentato dalla casa editrice Stampa Alternativa – Pietro Angelini. Il rammarico, tuttavia, è immediato nel constatare che nella bibliografia è assente proprio il libro di Snellgrove e Richardson, un riferimento imprescindibile per gli studi storici e culturali del Tibet. La ‘svista’ viene maggiormente evidenziata proprio da quanto affermato nella presentazione sul retro del volume, “sorretto da un’impressionante documentazione”. Il libro, in realtà, impressiona più per la sua incompletezza e per alcune scelte discutibili piuttosto che per la sua consistenza. Nessuno dei tanti libri scritti da Snellgrove viene citato in bibliografia, eppure, il suo nome compare a pagina 34 del libro, in cui Angelini, aprendo le virgolette, cita il tibetologo inglese senza, tuttavia, fornire alcun riferimento bibliografico. Del resto, nessuna indicazione precisa, riguardante le fonti o i fautori delle idee e teorie espresse nel libro è fornita nel volume. Nelle sue 353 pagine non compare alcuna nota. Si tratta, a mio avviso, di una scelta editoriale di discutibile onestà intellettuale, trattandosi, per di più, di un saggio storico. Il volume, anche in virtù di tali scelte metodologiche, non è adottabile come testo universitario ed è comunque insufficiente anche per essere letto da un pubblico di non esperti. Sono numerosi gli errori all’interno del libro che confondono il lettore e lo depistano, riscontrabili prevalentemente nelle parti riguardanti l’ambito culturale, religioso e filosofico. Le inesattezze più evidenti sono attribuibili al fatto che l’autore non è a conoscenza, evidentemente, di nessuna lingua orientale, limite che rende impossibile l’accesso alle fonti storiche in sanscrito o tibetano. Ci si aspetterebbe, infatti, che un “orientalista” conosca almeno una lingua orientale, competenza che ne determina la definizione stessa, peraltro ormai desueta e lievemente eurocentrica. Elaborare un’analisi storica senza avere accesso diretto alle fonti significa assemblare studi elaborati da altri, utilizzando un criterio personale e non sempre obbiettivo, con risultati spesso mediocri e di scarso valore scientifico.
I fraintendimenti e gli errori più evidenti, dovuti non soltanto all’impossibilità di consultare le fonti ma anche ad una difficoltà di destreggiarsi con gli strumenti disponibili (vengono citati in bibliografia autori senza alcuna competenza tibetologica mentre vengono ignorati autori come Snellgrove) sono, come già detto, prevalentemente legati alla sfera storico-religiosa e culturale. L’autore, ad esempio, utilizza il termine pundit (pp.86, 88, ecc.) per trascrivere foneticamente il sanscrito pa±¥ita, termina che designava i dotti indiani. Angelini utilizza una trascrizione fonetica inesatta e fuorviante visto che il termine sanscrito si legge esattamente come è scritto, mentre la sua trascrizione deriva dalla pronuncia inglese, che con pundit vuole indicare la pronuncia di pandit. Questo dimostra che l’autore ignora completamente la traslitterazione esatta di un termine assai comune e ricorrente in ambito storico-religioso indiano e tibetano. Traduce inoltre, a pagina 355 del glossario, il termine sanscrito guru e il suo corrispettivo tibetano lama (bla ma) con “amico spirituale, onorifico per i monaci di alto livello spirituale” anziché semplicemente ‘maestro’. L’appellativo lama viene usato anche per indicare i maestri di pittura, che certamente non sono degli ‘amici spirituali’. E inoltre assurdo pensare che il termine ne denoti il “livello spirituale”: basta compiere un viaggio in qualsiasi parte dell’Asia himalayana per rendersi conto che tutti i monaci, e sovente i maestri d’arte, vengono chiamati bla ma.
L’autore spesso fraintende informazioni trovate in alcuni degli studi da lui consultati. Ad esempio definisce (p.92) il maestro tibetano Marpa il “fondatore e capo spirituale della scuola kagyud”. Il maestro laico Marpa, cui fu discepolo Milarepa, viene riconosciuto dalla scuola ‘Kagyu’ (tib. bKa’ brgyud pa), e non kagyud, come uno dei maestri principali del proprio lignaggio in maniera retroattiva, poiché il primo monastero ‘Kagyupa’, quello di Dvags lha sgam po, viene fondato dal discepolo principale di Milarepa, Gampopa (1079-1153), parecchi anni dopo la morte di Marpa. Il primo monastero Kagyu a ricoprire una certa importanza, quando l’ordine si fu costituito, fu quello di gDan sa mthil, fondato dal discepolo di Gampopa Phag mo gru (1110-70) (Snellgrove e Richardson 1995: 135).
A pagina 8, Angelini definisce il Dalai Lama, apparentemente in modo ironico e del tutto fuori contesto, “Re dei re”. L’autore sostiene che la ruota d’oro che strinse in mano il capo spirituale e temporale del Tibet salendo sul suo trono fosse un “simbolo di onnipotenza”, mentre in realtà la Ruota o dharmacakra, simboleggia la ruota della legge, messa in movimento per la prima volta dal Buddha storico Sakyamuni durante il suo primo sermone nel ‘parco delle gazzelle’ di Sarnath.
All’inizio del paragrafo Il buddhismo tibetano (p.9), Angelini esordisce in questo modo: “Al tempo della sua prima diffusione in Tibet, il buddhismo delle origini – detto Hinayana o piccolo veicolo – era praticamente scomparso dall’India”. L’autore utilizza una distinzione tra piccolo e grande veicolo senza precisare che fu coniata dai praticanti della seconda tradizione in tono dispregiativo rispetto alla tradizione più antica. Lo stesso Dalai Lama, oggi, rifiuta questo tipo di distinzione fuorviante e non pertinente alla realtà storica e spirituale.
Alcuni passaggi sono incomprensibili e puramente frutto della fantasia dell’autore, che scrive: “i suoi discendenti costruirono una tomba regale in stile bon nello Yarlung” (p.49), inventando l’esistenza di uno “stile” del quale non ne chiarisce nemmeno l’ambito, se artistico, o architettonico, ecc. Ovviamente uno stile di questo tipo è del tutto inesistente.
Angelini, in più di un passaggio (p.69), confonde lo rDzogs chen – letteralmente ‘Grande Perfezione’ e non “Quelli della Completa Realizzazione” – con la tradizione giapponese dello Zen, e la sua corrispettiva cinese C’an, la quale presenta solo alcune affinità con la tradizione tibetana ma che certamente non può esservi identificata. A pagina 93 afferma che “Alcune caratteristiche dello dzochen sembrano provenire dalle più pure tecniche dei mahasiddha indiani e in seguito essere confluite nel buddhismo Zen”.
Utilizza spesso, per indicare la condizione di monaco, la parola “prete” (p.35, 87), termine inadatto a definire l’assunzione del voto di celibato in ambito tibetano, del resto improprio anche in ambito occidentale qualora si voglia indicare colui che sceglie di vivere la propria vocazione in ambito comunitario.
Fuorviante è anche la descrizione del traduttore tibetano Rin chen bzang po (958-1055), definito un “giovane mistico” (88) cosa che, casomai, diventerà in seguito. Dal modo in cui vengono descritte le vicende relative alla sua missione e alla sua opera di divulgazione si ha l’impressione che Rin chen bzang po abbia compiuto i suoi viaggi e studi seguendo una personale ispirazione. Non viene specificato, invece, che il monaco fu inviato in Kashmir, insieme ad altri govani, su incarico dei sovrani del Tibet Occidentale, per copiare, tradurre e interpretare, con l’aiuto di maestri indiani, i testi sacri del buddhismo e le pratiche liturgiche e rituali. Certamente egli seppe distinguersi e contribuì fortemente, con il suo lavoro di traduzione e con l’esperienza vissuta al fianco di importanti maestri (viaggiò in India tre volte rimanendovi per un totale di diciassette anni), alla rinascita spirituale del buddhismo nel Tibet Occidentale.
Si riscontrano errori anche nella parte dedicata ad Atisa Dipankara Srijnana, maestro bengalese vissuto nell’XI secolo. L’autore, descrivendo il celebre dotto indiano, sostiene che “Atisa, il cui nome indiano era Dipankara, era un maestro del buddhismo mahayana del monastero indiano di Vikramasila” (p.88), ritenendo forse, erroneamente, che il nome di Atisa sia tibetano e non indiano a sua volta e definendo “monastero” l’importante università monastica di Vikramasila, le cui rovine imponenti, ancora oggi, testimoniano la grandezza di questo centro di cultura, in cui venivano insegnate discipline come scienza, astrologia, teologia, e dove giovani provenienti da ogni parte dell’Asia si recavano per potervi studiare. “La cultura buddhista di Atisa”, secondo la lettura di Angelini, “era vastissima” (p.88), ma ciò che furono veramente vaste erano le sue conoscenze dottrinali e filosofiche. Egli era, infatti, un dotto buddhista e non uno studioso del buddhismo.
Angelini chiama inoltre, erroneamente, “Drom Tonkpa” (p.88) il discepolo che fu uno tra i più importati di Atisa, ‘Brom ston, la cui trascrizione fonetica dovrebbe essere Drömtön. Riportare in maniera errata e personalistica nomi e toponimi può risultare fuorviante per il lettore e limitante per eventuali approfondimenti.
All’interno del libro ci sono frasi poco chiare riguardanti l’ambito dottrinale e religioso, come ad esempio: “Va detto che tradizionalmente tra le scuole buddhiste non vi è alcuna differenza nel loro stadio finale, perché insegnamenti diversi si riscontrano solo nella Via” (p.89). Ancora, dopo aver definito la via dei tantra una “scorciatoia verso l’illuminazione” dice “Ma è anche vero che come ogni scorciatoia, è anche la più pericolosa, in quanto la libertà d’azione può portare il praticante poco sorvegliato verso i fondali bassi dell’io e affogare in quei veleni che si vogliono trasmutare, nevrotiche quanto effimere consistenze dell’io capaci di spedire l’adepto nell’inferno di debiti karmici di più gravosa entità” (p.90). La frase non è formalmente chiara e soprattutto non lo è il concetto che l’autore vuole esprimere. In nessun testo viene detto che la via dei tantra sia la più pericolosa. La libertà d’azione si trova in tutte le tradizioni del buddhismo, che insiste molto sulla comprensione intellettuale e non solo su un cieco atteggiamento fideistico. Inoltre, è proprio in questa via, dove viene data grande importanza al ruolo del maestro e allo stretto legame tra lui e il discepolo, che l’adepto non viene mai lasciato solo. Anche il concetto di “inferno dei debiti karmici” appare in contrasto con la tradizione buddhista e più vicino a quella cristiana occidentale.
Un'altra frase fuorviante è la seguente: “E anche fuori dalle università, presso gli asceti o negli ashram himalayani, dove forse le pratiche erano meno rituali e più effettivamente sperimentali, vigeva una profonda differenza nella trasmissione secondo una distinzione di condotte basate sul livello di preparazione e persino di santità” (p.91). Oltre ad usare in modo improprio il termine ashram, che non si addice alla tradizione buddhista tibetana, l’autore descrive in modo assolutamente immaginativo il tipo di condotta tenuto in questi gruppi di discepoli che si trovavano per scelta a vivere al di fuori dei centri monastici. Non è esplicito ciò che Angelini intenda per sperimentale. Errata è invece la considerazione sul livello di capacità dei discepoli in base al quale i maestri davano loro istruzioni: anche in ambito strettamente monastico la procedura era la stessa. I testi tantrici in generale, come ad esempio l’Hevajra tantra, offrono di partenza soluzioni diverse in grado di rispondere alle differenti capacità spirituali dell’adepto e del suo personale livello di evoluzione.
Discutibile è l’uso dei termini “berretti rossi” (p.93) o “berretti gialli” (p.104), che ricorrono molte volte nel testo. A questo proposito cito Erberto Lo bue che in questo modo ha commentato l’uso del termine ‘berretto’ nella sua recensione alla pessima traduzione del volume di Snellgrove e Richardson di Luni editore: «Di sapore un po’ folcloristico e quasi militaresco è la traduzione del titolo della terza parte, “I berretti gialli”, con riferimento ai seguaci dell’ordine religioso dGe lugs pa (letteralmente “Quelli del Modello di Virtù”): chiunque conosca la foggia dei copricapo indossati dai monaci di quell’ordine in alcuni rituali converrà che l’uso del termine “berretto” per rendere l’inglese “hat” è in tale contesto discutibile» (Rivista degli Studi Orientali, 200, Roma, vol.LXXIII, Fasc.1-4 (1999), p.336). Non si comprende il motivo della scelta del termine “berretto” da parte di Angelini, che a p.104 dice: “La scuola dei ghelupa, detta anche dei ‘berretti gialli’ – dal colore del cappello che Tsonkapa adottò come copricapo religioso a differenza del rosso dei kagyu”. Sembra consapevole si tratti di cappelli e non berretti, dunque risulta incomprensibile il motivo di tale scelta. In realtà, inoltre, il colore del cappello non è distintivo di una scuola in particolare. In Ladakh, ad esempio, vengono chiamati ser po (‘gialli’) sia i monaci appartenenti all’ordine dGe lugs pa che quelli appartenenti all’ordine Sa skya pa.
Assolutamente inaccettabile è la mancanza di citazioni riguardanti le fonti utilizzando parti di testi altrui, come ad esempio accade a p.97-99 e in molti altri passaggi. Quando si aprono le virgolette e si riporta un brano originale è necessario e corretto citarne la fonte.
La descrizione generale della figura di Tsong ka pa, che appare come un Martin Lutero della tradizione buddhista himalayana, è alquanto discutibile. Angelini scrive: “egli si impegnò in una grande riforma che aveva il fine di raddrizzare l’insana postura del sistema e poneva l’accento sulla necessità di maggiore e ferrea disciplina monastica” (p.105). È certamente vero che fu un maestro critico verso tutte le forme di degenerazione religiosa, ma fu egli stesso uno yogin (veste nella quale viene spesso raffigurato), particolarmente interessato ai tantra, e un grande mistico. Passò gran parte del suo tempo in ritiri di meditazione che duravano anche anni ed ebbe un atteggiamento, tutto sommato, piuttosto schivo, soprattutto nei confronti delle grandi personalità politiche dell’epoca. Dire che “si impegnò a fondare e dirigere una grande quantità di monasteri aderenti al nuovo indirizzo riformatore” risulta contrastante con la personalità di Tsong ka pa, che addirittura si trasferì a vivere in monastero solo durante la vecchiaia e in seguito all’insistenza dei suoi discepoli.
Altre incongruenze sono rintracciabili nella narrazione delle vicende biografiche del V Dalai Lama. Descrivendone l’apertura mentale e l’atteggiamento non settario, Angelini afferma: “Sebbene educato nella più stretta ortodossia ghelupa, col tempo egli sembrò comprendere la ricchezza non settaria degli insegnamenti buddhisti e si avvalse nella maturità del contributo di numerosi maestri delle più svariate tradizioni fra le quali i nyigmapa” (p.119). La madre del V Dalai Lama (1617-82) era di tradizione Nyingmapa. Crebbe dunque in ambiente Nyigma e fu educato secondo questa tradizione. Solo in seguito al suo riconoscimento ricevette insegnamenti più strettamente dGe lugs pa, ma coltivò sempre il contatto con la scuola d’origine e con i maestri della suddetta tradizione. Nel descrivere il rituale del gCod, praticato dal V Dalai Lama, Angelini parla di “preta invocati” per “divorare il corpo del meditante che si offre in sacrificio” (119). Chiaramente, gli esseri invocati in questo rituale non sono che proiezioni mentali, poiché, come sostenuto da Giacomella Orofino “la radice di qualsiasi demone è da ricercare nella propria mente” (Ma gcig, Canti spirituali, a cura di G.Orofino, 1995, Milano: Adelphi), e l’offerta di sé a queste creature è rituale e simbolica. Ciò che viene reciso, attraverso il dono del proprio corpo, è l’orgoglio. Occorre precisare, inoltre, che gli esseri invocati durante il gCod sono demoni o spiriti feroci e non preta, i quali sono esseri famelici dotati, per loro natura, di una gola strettissima che non gli consente di ingerire altro che poche gocce d’acqua.
Imprecisa è anche questa affermazione: “Il sistema (monastico) non verificava le vocazioni, né espelleva i novizi non adatti ad una vita di preghiera, studio e meditazione, contemplando l’espulsione solo per delitti gravi, quali l’omicidio o le relazioni eterosessuali” (p.128). È noto che all’interno di istituzioni esclusivamente maschili quali i monasteri si verificassero relazioni omosessuali, ma questo non significa fosse la prassi e che tali rapporti venissero accettati. L’affermazione di Angelini lascia presumere l’opposto, contrariamente alla regola vigente del celibato.
Un’altra affermazione di ignota provenienza è la seguente: “Costruire un tempio è infatti considerato nel buddhismo tantrico un atto di conquista spirituale di un determinato territorio: sigilli magici iscritti in un cosmogramma che ridefinisce uno spazio e ne attesta il possesso segreto, fabbrica di tecnologia sacra e laboratorio alchemico di scienza spirituale” (p.201).
A pagina 211 l’autore identifica correttamente la divinità sino-giapponese Guanyin con il bodhisattva Avalokitesvara ma poi sostiene che ne sia anche l’“antagonista metafisica”, affermazione oscura e scarsamente giustificata, dato che si tratta della stessa divinità.
Concettualmente errata è la definizione di “Buddha viventi” (226) attribuita a maestri spirituali e alla figura del Dalai Lama, poiché i maestri terreni che abitano questo mondo non posso essere tecnicamente dei Buddha, in quanto tale condizione presuppone la morte definitiva e la non-rinascita sotto alcuna forma di vita, al momento del trapasso nel Nirvana. Nessun maestro viene chiamato, nella tradizione buddhista tibetana, in questo modo. Nemmeno il Buddha storico Sakyamuni, che nei testi viene chiamato ‘Grande Bodhisattva’. Chiamare Reting Rimpoche, maestro del Dalai Lama eliminato per motivi politici, “Buddha di Reting” (p.251), con tono vagamente sarcastico, appare esagerato e fuori luogo.
L’autore, riferendosi alle punizioni corporali che potevano verificarsi negli ambienti monastici, sostiene che queste fossero “la norma nella loro stessa pratica religiosa” (227). Pur ammettendo che le punizioni corporali fossero davvero la “norma”, lo sarebbero nella pratica ‘monastica’ e non ‘religiosa’.
A pagina 228 parla di “forze occulte”, piuttosto che di ‘forze oscurantiste’, parlando dell’atteggiamento di chiusura del clero tibetano al potere.
Tal volta, Angelini sembra poco informato sui fatti, ad esempio quando scrive: “Finiva così la carriera di Tsarong, la cui unica colpa fu quella di essere un fuori-casta” (p.228). In realtà, Tsarong apparteneva ad una famiglia dell’aristocrazia tibetana e quindi non poteva certo essere considerato fuori casta, se il termine è usato nel suo corretto significato etimologico e letterario. Se con la parola ‘casta’ Angelini voglia intendere il termine con cui oggi in Italia viene chiamata la nostra classe politica, allora avrebbe dovuto dire “fuori dal gioco politico di alcuni”.
Eccessivamente enfatizzata è la descrizione dell’infanzia dell’attuale Dalai Lama, che viene descritto come un bambino strappato alla sua famiglia in giovanissima età. È noto che la famiglia del Dalai Lama, si trasferì da un piccolo villaggio del Tibet orientale a Lhasa, dove visse accanto al giovane Dalai Lama. Inoltre, poche righe sotto, Angelini, raccontando la prima visita del Dalai Lama in Cina, quando era ancora molto giovane, sostiene che fu accompagnato dalla sua famiglia. Appare contrastante il fatto che un bambino strappato alla sua famiglia compia i suoi viaggi diplomatici con ancora la madre e i fratelli al seguito.
.
Il linguaggio stesso, usato da Angelini, risulta poco gradevole, talora grossolano e, comunque, non pertinente al soggetto trattato. A questo proposito si vedano le seguenti frasi: “vi sono nel nord rimasugli etnici tibetani” (p.6); “altri luoghi da cui i tibetani attinsero maestri e traduttori” (p.10); “una sorta di preti di famiglia” (p.35); “è tempo che entri in scena uno dei grandi protagonisti della nostra storia” (p.57); “si dovrà traversare la pelle di quattro secoli prima di ritrovare un Tibet unito” (p.85); “in grado di accogliere i migliori rimasugli della comunità buddhista” (p.87); “in seguito ai travasi intellettuali” (p.88); “La trasmissione dzochen, un po’ nello stile di Marpa, non dipende…” (p.93); “La linea degli scopritori di tesori nascosti inizia con gente del calibro di Dorje Zangpo” (p.94); “mito che crebbe in seguito e si delineò secondo arzigogoli della mente che non hanno ancora finito di stupire gli strizzacervelli” (p.123); “Inoltre quella del monastero non era di istruzione, o di educazione temporanea, ma una scelta di vita, con le motivazioni più diverse: alcuni genitori coronavano la loro fede, in quanto un figlio in monastero era un onore, oltreché un privilegio” (128); “Chi prima era un compagno di merende ora era un nemico da flagellare” (193); “Gyalo era (…) fluente in cinese” (302).
Per finire con veri e propri effetti speciali: “un mega ciclo calcolato a partire dal Nirvana del Buddha, stelle e pianeti che tornano senza esser presenti, catapulte con cui sconfiggere il nemico nella ‘battaglia finale’, divinità da visualizzare nella meditazione e poi sangue e sperma che giacciono come tesori inesplosi nel corpo degli esseri senzienti. E una ruota del tempo, Kalachakra, da conoscersi in quindici fasi, nel vuoto della trasmissione iniziatica. Essa ha il potere di liberare l’individuo dall’ignoranza del Tempo e dunque di estirpare il cancro della Storia nel mondo” (p.7). Di tono volutamente sensazionalistico è anche la frase di pagina 91, “Vi erano così monaci banditi, che uccidevano e si cibavano di carne umana e si abbandonavano ai più frequenti riti orgiastici a base di alcol e sesso credendo con questo di illuminarsi”, che appare esagerata e contraddittoria. Se si trattava di “monaci banditi” risulta chiaro che il loro intento non era certo quello di illuminarsi bensì di approfittare di uno status per fare tutt’altro. “Con le mani nel sangue ormai da tre secoli, si ripeterono macabri riti di morte, macumbe tibetane, intrighi, diplomatiche stregonerie di incalliti negromanti” (p.116.
Ciò che emerge da una prima lettura di questo libro è l’intento, encomiabile, di descrivere in maniera oggettiva il susseguirsi di vicende e di responsabilità politiche che hanno modellato la storia del Tibet e la recente aggressione subita da parte della Cina. Tuttavia, il libro scade in esagerazioni e sensazionalismi che non fanno che gettare fumo negli occhi del lettore. Purtroppo non è sufficiente servirsi unicamente della letteratura secondaria sulla storia del Tibet, anche se cospicua. Per avventurarsi saggiamente in un universo culturale così vasto e complicato è necessario essere guidati da un maestro esperto, poiché, per dirlo con le parole dello stesso Angelini, arginare il confronto con un maestro può risultare una “scorciatoia pericolosa”, che può portare lo studioso “poco sorvegliato verso i fondali bassi dell’io e affogare”.
|